In questo mio scritto il termine generazionale potrebbe correre il rischio di risultare troppo pretenzioso.
E allora pensiamo ad un percorso personale, il mio, nel quale almeno qualcuno della mia generazione potrà identificarsi.
Un percorso che chiamerà in causa alcuni libri, ancora una volta a sostegno della tesi che ci può essere un ”mestiere del lettore” e cioè un modo attivo di leggere: una lettura come momento di riflessione sul proprio percorso di vita; una lettura capace di chiarire almeno in parte il senso della propria esistenza (il ”da sein” della lingua tedesca, l’essere qui ed ora); una lettura che permetta almeno per un attimo di realizzare una nostra ”weltanschaung” e cioè di afferrare una visione personale ma anche collettiva del mondo e del nostro modo di essere in esso.
Mi farà da guida il volume di Domenico Scarpa in uscita il prossimo mese di ottobre (”Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore” Hoepli). Un libro colto che fornisce una lettura interessante e stimolante di Italo Calvino uomo e scrittore.
Prenderò a prestito alcuni spunti tratti dalla lettura in anteprima di questo lavoro.
A partire da quella che viene definita la ”frattura vistosa”: <<in un breve giro di anni, tra la fine dei cinquanta e la metà dei sessanta, molti autori italiani di primaria grandezza si sono trovati davvero come su un ponte dalla campata altissima…al sommo dell’arco ciascuno di loro ha visto, guardando in giù dall’altra parte, un paesaggio nuovo e precipitoso, diverso da quello a cui si era abituato nel primo tratto del dopoguerra>>.
Scarpa sta parlando di quel Calvino che Marco Belpoliti definisce ”un individualista che ha il senso del lavoro collettivo”, un Calvino che appunto a metà degli anni sessanta <<si accorge una volta per tutte che non riuscirà mai a influire veramente e direttamente sul proprio tempo>>.
E’ soprattutto il Calvino delle ”Città invisibili” che apre un rapporto dialettico con il Pasolini degli ”Scritti corsari” e di ”Petrolio”, con la Morante de ”La storia”, con il D’Arrigo di ”Horcynus orca”, con il Parise de ”L’odore del sangue” (ai quali, da parte mia, aggiungerei il Neri Pozza del ”Diario 1963-1971”, il Piero Calamandrei de ”Lo stato siamo noi”, il Nicola Chiaromonte di ”Fra me e te la verità”, ma potremmo aggiungere tanti altri che in quel momento avvertivano con sofferenza il corso di una società destinata ad un triste declino sociale, morale, spirituale).
A questo punto è possibile mettere a confronto la frattura di quella generazione con la frattura della mia generazione, collocabile a mio parere tra la metà degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. Il momento in cui si imbocca la strada della globalizzazione e si entra nel trionfo del capitalismo finanziario.
Ancora negli anni settanta e nei primi ottanta si credeva nel ”piccolo è bello”, una fiducia che poi è stata sostituita dal bisogno del grande, sempre più grande. Abbiamo lasciato che si affermasse la cosiddetta ”società liquida”, una società dominata dal rumore, dalle apparenze, dal protagonismo e soprattutto dalla concentrazione della ricchezza nelle mani di un numero sempre più piccolo di uomini, padroni di strumenti potentissimi coi quali poter dominare una sempre più grande massa di poveri.
Nel frattempo è scomparso il vero ruolo dei partiti, dei sindacati, dei movimenti. I giovani sono stati privati di tutti quegli strumenti che in precedenza si sperava potessero servire in qualche modo ad influire sul corso degli eventi. E un giovane al quale si è tolto il desiderio di poter cambiare il mondo è un giovane povero di prospettive, di entusiasmi, di speranze; diventa ”un giovane individualista che ha smarrito il senso del lavoro collettivo”.
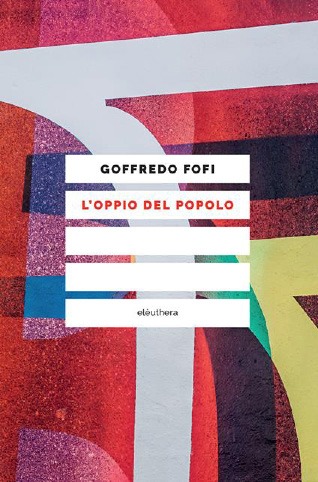
La responsabilità non può che essere nostra, della nostra generazione. Una generazione che ha vissuto questo percorso come un processo inevitabile, dovuto si, ma forse anche inconsciamente voluto.
Nel mio caso, ma penso sia stato così anche per molti altri, si è progressivamente sviluppata una sempre più forte insofferenza, una rabbia anche quotidiana, accompagnate però da un senso di impotenza, dalla sorda accettazione del ”fare il meno peggio possibile”.
Rassegnazione? Forse no o non del tutto, poiché la volontà di continuare a lottare non è mai venuta meno, anche se sempre con la coscienza di star combattendo una battaglia donchisciottesca.
Fallimento? Forse si, in quanto alla fine a prevalere è stata una società dominata dal regno della quantità, dal bisogno di fare grandi numeri, numeri sempre più grandi a scapito della dimensione etica, professionale, culturale.
Il conseguente dissidio personale può trovare un’ottima definizione nella seguente frase tratta sempre dal libro di Domenico Scarpa: <<ma il silenzio, gelido vento, di tanto in tanto attraversato da risonanze, da piccoli diapason, da lilliput avvolti nel sudario dei bagni turchi, il silenzio dico è la tentazione maggiore. Ed è una tentazione estetica prima di tutto, non tanto una necessità filosofica (com’è però)>>.
Anche il mestiere da me svolto in questi quarant’anni si è trovato ad essere sconvolto, sopraffatto dal fiume prepotente di una sovrapproduzione editoriale sempre più povera di equilibrio e qualità.
E così possiamo dire di aver contribuito anche noi, coscienti o incoscienti, alla trasformazione della cultura in ”oppio del popolo” (questo è il titolo di un libro di Goffredo Fofi pubblicato da Eleuthera: un lavoro forse troppo ripetitivo e molto accusatorio, ma certamente efficace nello spiegare in modo convincente come la cultura sia appunto diventata un nuovo oppio del popolo). Una sorta di ”sfascismo”: non so se altri abbiano mai usato questo termine, ma a me sembra opportuno utilizzarlo per rimarcare come si sia arrivati a ”sfasciare” un certo mondo culturale, contaminandolo con tanti elementi di quella forma di ”fascismo” intellettuale-politico-sociale contro il quale gli scrittori in precedenza citati si scagliavano, mettendoci inutilmente in guardia.
Non possiamo dimenticare come Pier Paolo Pasolini parlasse di ”mutazione antropologica”: un pericolo che non abbiamo saputo fronteggiare adeguatamente col risultato di avere oggi una cultura anch’essa molto adatta a addormentare, omologare, schiavizzare.
Possiamo rivolgerci ancora una domanda a partire da quest’altra frase: <<fatto sta che il messaggio non verbale che ci arriva dal meglio del secolo scorso sembra suonare così: stiamo naufragando e non c’è salvezza, però vediamo di tramandarci al futuro, vediamo come approdare al futuro sotto forma di una forma che sia bella da guardare>>: riusciremo noi a salvare almeno qualcosa di questo proponimento?
Ed ora affidiamoci ad un ultimo passaggio, affatto pregnante, che dovrebbe suonare come forte monito per tutti quelli che lavorano con i libri (scrittori, editori, librai…): <<i libri necessari degli anni settanta italiani nascono da solitudini che spesso sono costate un dolore non soltanto intellettuale; nascono da un lavoro che ha conosciuto la disperazione, o quantomeno una malinconia che non ha trovato rimedio. Nascono, in un certo senso, da un auto seppellimento prematuro da parte di chi li ha scritti. Prima che per noi lettori, quei libri sono stati una necessità per chi li ha dovuti scrivere parola per parola. Staccarli da sé era una questione di vita o di morte>>.
Partendo da questa frase potremmo aprire un altro lungo discorso sul significato del ”mestiere di scrittore e di lettore” nonché sul ruolo del libro come strumento di miglioramento, strumento volto a lasciare il mondo almeno un po’ migliore rispetto a prima. Vorrei invece terminare con una doverosa precisazione personale: mi sono permesso di accostare il mio percorso generazionale a quello di uomini di grande talento, talento più o meno grande ma grande. C’è però la piena coscienza di non essere un intellettuale e più ancora di essere una formichina dal punto di vista culturale. Mi considero persona provvista di una ”superficial-cultura”, nel senso di essere destinato a toccare tanto senza nulla approfondire. Però mi sforzo di essere ”lettore di mestiere” sperando che il tentativo di interpretare le cose della mia vita anche attraverso gli scritti di persone ragguardevoli possa trovare un minimo di legittimtà.


