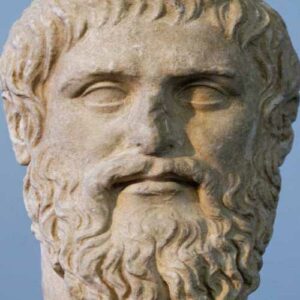Retorica e sport
Nei discorsi che riguardano lo sport una grande distinzione può essere fatta: quella fra i discorsi che parlano direttamente di sport e quelli che entrano nel merito di aspetti in qualche modo laterali, cioè che riguardano lo sport ma invece di riferire la descrizione di un evento si propongono una riflessione su ciò che è collegabile all’evento. Proprio qui è possibile individuare spazi per la retorica che, essendo l’insieme delle tecniche per rendere il discorso più efficace, intende fornire una serie di possibilità di interpretazione in più rispetto a quelle proposte dalla semplice descrizione.
Infatti, proprio aumentando il numero delle possibilità di interpretazione è possibile far scattare quella specie di corto circuito interpretativo che, accostando uno schema di ragionamento in qualche modo condivisibile ad un altro più difficile da accettare, permette di accettare anche il secondo grazie all’analogia fra i due schemi di ragionamento. Questo è possibile perché il ragionamento retorico è volto più a suscitare emozioni che a illustrare argomentazioni, sicché elimina i passaggi logici e utilizza le suggestioni.

collezione di Massimo-Lancellotti – Livioandronico2013
In effetti il numero dei discorsi che possono essere fatti per render conto degli eventi sportivi dovrebbe essere limitato. Certo si possono fare discorsi più adeguati, più diffusi e più approfonditi, e questo ne fa crescere il numero. Ma le esigenze dei media, che vogliono un pubblico sempre più vasto, inducono a moltiplicare in tanti modi le occasioni in cui si parla di eventi sportivi.
Ora, parlare degli eventi, dei “fatti” sportivi è una cosa che finirebbe abbastanza presto: ne fai la cronaca e la cosa finisce lì. Ma il bello delle cronache è che dopo puoi mettere a confronto le diverse visioni, così da far scattare una nuova competizione: quella fra i commentatori, fra i tifosi delle diverse squadre o dei diversi atleti (oppure, in politica, fra i partigiani dei diversi partiti), o dei diversi modi di ottenere il risultato. In altre parole, nietzschianamente: non esistono fatti ma solo interpretazioni, perché ogni fatto viene colto secondo l’ottica della cultura di chi lo percepisce, e questo condiziona ogni descrizione, che non è neutra ma carica di “ideologia”, e questa ideologia va smascherata come tutte le ideologie sottese alle varie descrizioni. Ecco dunque un buon sistema per continuare a discutere di sport (o di politica) anche quando il materiale su cui esercitare la discussione sembrerebbe terminato.
Allargare le possibilità di parlare di sport

Per soddisfare l’esigenza di allargare la possibilità di parlare di sport (o di politica) sono possibili diversi sistemi.
a) Il primo sistema consisterà, ovviamente, nel puntare sui commenti piuttosto che sulla descrizione di eventi. Non esistono fatti ma solo interpretazioni abbiamo detto prima, e questa affermazione è sicuramente fondata. Si potrebbero allora esaminare le diverse interpretazioni per individuare quella più soddisfacente. Così però qualcuno dei commentatori risulterebbe “vincente” e qualcun altro “perdente”. Stessa cosa avverrebbe fra il pubblico e l’effetto collaterale sarebbe che la parte “perdente” potrebbe anche decidere di non seguire più quella trasmissione. Perdere pubblico (e pubblicità) però non è certo l’obiettivo di chi organizza dibattiti televisivi, quindi conviene cambiare obiettivo e puntare sul dibattito come spettacolo: il dibattito che dovrebbe essere il mezzo per giungere a concludere quale sia la più attendibile fra le diverse interpretazioni del “fatto” in discussione, diventa invece il fine.
b) Un altro efficace modo per dilatare di spazi e tempi da dedicare allo sport consiste nell’uso di artifici per “vedere” nell’evento sportivo aspetti che sarebbero marginali ma che vengono proposti come rivelatori di aspetti extra-sportivi allargando così l’insieme delle cose di cui parlare. Qualche esempio: il labiale da cui si capisce che Tizio sta telefonando alla mamma per comunicarle il successo appena conseguito, oppure che Tizio mentre parla con Caio critica Sempronio. Cose che con gli aspetti strettamente sportivi, agonistici, non hanno molto a che vedere, ma che permettono di capire che esseri apparentemente superiori a noi perché vivono in un Olimpo al quale vorremmo avere accesso, ci sono in realtà assai simili per quanto riguarda affetti e debolezze. Questo consente di mettere in relazione quel mondo con quello di noi comuni mortali e catturare la nostra attenzione. Ma per farlo bene bisogna essere convincenti, ed è la retorica lo strumento che permette di rendere accettabile, ovvio ed opportuno questo riferimento ad aspetti marginali. E così è sempre stato, da quando ci si è accorti che il linguaggio poteva essere utilizzato, oltre che per descrivere, narrare e dare ordini, anche per convincere qualcuno a fare quel che gli chiedo, non quello che farebbe di sua iniziativa.
La retorica ha dunque una storia lunga: almeno 2500 anni di (non sempre) onorato servizio, sicché può essere utile qualche riferimento alla civiltà dei Greci antichi, perché sono stati loro ad utilizzarla senza remore, a metterne in chiaro pregi e limiti e a darle una sistemazione teorica che, per le tesi di fondo, ha ancora la sua validità.
Aristotele, ad esempio, elaborò le sue riflessioni sulla retorica quando molte cose erano già state dette sull’arte di “rendere efficace il discorso”: Empedocle aveva dato lezioni di eloquenza a pagamento e Corace, un suo allievo, aveva pubblicato, nel 460 a.C., il primo manuale di retorica. Il motivo era che la transizione della polis da istituzioni aristocratiche ad istituzioni democratiche, con tutto il popolo che partecipava col voto alla gestione della cosa pubblica, aveva posto l’importante problema di come fare per convincere la gente a votare per una scelta politica piuttosto che per l’altra.
Aristotele lavorava quindi un terreno già dissodato e nel proporre le sue classificazioni era sottile e circostanziato; riguardo alla retorica come scienza dei tipi di discorso (e dei corrispondenti tipi di ragionamento), proponeva una tripartizione ancora valida che ora proviamo ad esaminare sommariamente. Innanzitutto c’è il discorso di tipo analitico, che parte da due premesse che sappiamo già essere vere, e da esse trae una conclusione apodittica sicuramente altrettanto vera: è il discorso utilizzato dalle scienze per costruire e ordinare secondo criteri razionali ciò che i sensi ci hanno mostrato riguardo alla realtà che ci circonda; in secondo luogo c’è il discorso dialettico: funziona come il discorso analitico, solo che la verità delle premesse non è certa ma solo probabile, e tale sarà anche la validità delle conclusioni (da notare che “probabile” va inteso proprio nel senso etimologico: qualcosa che può essere provato, anche se ancora non lo è); infine c’è il discorso retorico.

Riguardo alla capacità di dire il vero sull’argomento di cui parla, quest’ultimo tipo di discorso è svantaggiato rispetto agli altri due che. partendo da premesse vere (il discorso analitico) o almeno probabili (il discorso dialettico), se eseguono correttamente tutti i passaggi, giungono a conclusioni vere o almeno probabili. Il discorso retorico invece parte da premesse non necessariamente vere e neanche probabili: potrebbero anche esserlo ma, quando il discorso viene proposto, questo non è importante. Siccome il discorso intende essere efficace, convincente, allora è importante che le premesse siano condivise da chi ascolta. Anzi, è ancora meglio se le premesse sono sottintese, in modo che chi ascolta non abbia dubbi sulla loro condivisibilità.
Platone, invece, dopo una prima fase di condanna della retorica rivede la sua posizione e ne individua un uso “buono” grazie al quale è possibile far crescere la conoscenza. Nel discorso dialettico, infatti, ci si fonda su premesse probabili per giungere a più conclusioni alternative che sono sulla strada della conoscenza ma non l’hanno ancora raggiunta, dunque bisognerà confrontarle – col dialogo – per vedere quale risulta più “efficace” a fini cognitivi. Diventa quindi importante produrre discorsi efficaci: non discorsi veri come quelli del discorso analitico, perché quelli muovono da premesse vere che ancora non abbiamo, ma discorsi verosimili, probabili, come le premesse dalle quali derivano. La retorica, a questo punto, può servire alla conoscenza perché può dare maggiore efficacia ad alcune ipotesi piuttosto che ad altre in modo da giungere a conclusioni condivise, visto che si era partiti da premesse condivise. Che è invece – diciamolo per inciso, ma l’abbiamo già visto – l’esito accuratamente evitato dai vari talk show, sia a tema sportivo che politico.

Naturalmente per giungere al risultato che voleva Platone bisogna fare della dialettica un uso onesto: usarla non per far diventare forte il discorso debole con “ornamenti” che lo rendono accattivante, ma per fare in modo che tutte le ipotesi che sono in discussione si trovino “ad armi pari”, esplicitandone la ricchezza e le potenzialità cognitive grazie agli strumenti della retorica, cioè puntando sulla condivisibilità di alcuni aspetti di queste ipotesi.
Questa condivisibilità ha un carattere particolare: deve appartenere alle premesse, altrimenti chi ascolta non riesce a comprendere, ma è anche l’obiettivo perseguito da chi costruisce, ad esempio, un discorso deliberativo col quale indurre un’assemblea o singoli individui a prendere una determinata decisione: la condivisibilità del discorso è mezzo e fine contemporaneamente. La riflessione su questo aspetto richiede però che vengano presi in considerazione altri fattori importanti. Gli studi del XX secolo sulla comunicazione hanno chiarito che, affinché un messaggio riesca a comunicare qualcosa, occorre che emittente e destinatario abbiano lo stesso codice, cioè che grammatica, sintassi e semantica di chi costruisce il messaggio e di chi lo riceve coincidano: il codice deve essere condiviso. Per una comunicazione perfetta ci vorrebbe una perfetta identità di codice, ma si tratta di un caso limite che in pratica si verifica solo nella comunicazione fra macchine (telefoni, computer, …), mentre nella comunicazione umana ci si deve accontentare di una coincidenza (di una condivisione) parziale.

Questo vale non solo per gli aspetti “visibili” del discorso, ma soprattutto per quegli elementi che, pur rimanendo nascosti, hanno però nella comunicazione un ruolo fondamentale. Tali elementi sono quelle premesse che nel discorso retorico vengono date per scontate. E fra queste – in ogni tipo di discorso – ci sono anche i valori, i criteri per mezzo dei quali tutti i discorsi vengono valutati. I valori, nella costruzione dei discorsi (di tutti i discorsi: etici, politici, estetici ed anche cognitivi) vengono dati per scontati per il semplice motivo che, essendo il fondamento del valore di quei discorsi – ciò che ne definisce il senso – non possono essere espressi. In effetti il senso di qualsiasi cosa non sta nell’orizzonte, nel “mondo” in cui quella cosa esiste, ma in un altro luogo: quello della sua valutazione. Il senso di qualsiasi cosa non sta nel linguaggio che ne dà una descrizione ma nel metalinguaggio con cui si parla di quella descrizione, Dice efficacemente Ludwig Wittgenstein: “Il senso del mondo deve essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, tutto avviene come avviene; non vi è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore. Se un valore che ha valore v’è, dev’esser fuori d’ogni avvenire ed essere-così. […] Dev’essere fuori del mondo.” [Tractatus logico-philosophicus, proposizione 6.41]. In altre parole, è evidentemente possibile, nel metalinguaggio, esprimere una valutazione, ad esempio dei comportamenti, ma questo può essere fatto solo dicendo quali azioni sono buone e quali non lo sono, e non dicendo in maniera argomentata in cosa consiste il Bene. E questo vale anche per il Bello. Citando nuovamente Wittgenstein: “È chiaro che l’etica non può formularsi. L’etica è trascendentale. (Etica ed estetica son uno)” [Opera cit., proposizione 6.42].
L’unico strumento linguistico è quello retorico
Si capisce a questo punto che se si intende decidere se un valore ha valore (ovvero: se è legittimo utilizzare un criterio di valutazione), l’unico strumento linguistico disponibile è quello retorico. Non però nel senso che mi metto ad usare qualche trucchetto linguistico per irridere chi non condivide il valore (etico, politico o estetico) che sto proponendo, e portando così il pubblico dalla mia parte. Nel senso invece – culturalmente assai più profondo – che “mostro” che tutti ci possiamo riconoscere in quel valore: faccio leva sul senso di appartenenza che i destinatari del mio messaggio dovrebbero sentire rispetto alla cultura che ha prodotto i valori che propongo e il linguaggio che ne permette la comunicazione: se comprendete i discorsi che vi faccio, comprendete anche quanto sono alte e belle e nobili le cose di cui vi parlo, ed anche quanto sono alti e belli e nobili i valori con cui le giudico. In questo modo sentiamo di appartenere tutti a quel mondo e ci sentiamo tutti più alti, più belli e più nobili.
E soprattutto nei momenti di crisi, quando compattare la comunità diventa più importante, la retorica ha un ruolo insostituibile. Perciò è importante, come è successo di recente fra Europei di Calcio ed Olimpiadi, sottolineare i successi sportivi. È facile che ci si identifichi con un atleta: la forma fisica invidiabile, la capacità di controllo del corpo sono qualità che anche un poltrone incallito è disposto a riconoscere. Se poi l’atleta vince, l’identificazione è quasi ovvia. Allora puntare su questo proponendo l’atleta vincente come modello della (e per la) comunità significa suggerire che ci riconosciamo tutti in quel modello, e la comunità diviene più compatta. Che in tempi di individualismo edonistico (ed egoistico) assai spinto non è un risultato da sottovalutare. E se, oltre a concedere ai vincitori la gloria del primo posto in tv, oltre ad accettare che facciano il giro trionfale nella capitale come gli antichi generali romani, si fa anche un po’ di retorica su tutti gli altri valori accessori (il senso della famiglia e dell’amicizia, la disponibilità al sacrificio per ottenere il risultato, …) che fanno parte della vita dei campioni come di tutti i comuni mortali, si riesce pure a far passare in secondo piano tante altre magagne piccole e grandi che travagliano la comunità.

In realtà la nostra comunità di magagne ne ha diverse, e neanche marginali. Questo vale non solo se per “comunità” intendiamo la società italiana, ma anche se indichiamo l’insieme di società che vanno di solito sotto il nome di civiltà occidentale e pure se allarghiamo il senso del termine a comprendere l’intero genere umano. Qualche esempio.
Innanzi tutto i conflitti fra classi sociali. Apparentemente non ce n’è, ma solo perché guardiamo la realtà attraverso la crescita/decrescita del PIL che è l’esito dell’interazione fra le classi, e non badiamo (perché il PIL non lo dice) a chi ha fatto che cosa per ottenere quel risultato, come quando ti gusti una pietanza e non badi agli ingredienti che la costituiscono ed alle loro interazioni. Anche se è proprio da quelle cose che dipende il gusto di quella pietanza. Un altro aspetto problematico delle società contemporanee è costituito dalla mancanza di senso di appartenenza: ogni individuo persegue il suo personale tornaconto e non bada minimamente al fatto che il suo interesse entri in conflitto con quello altrui. È l’esito della cultura individualistica che ci viene propagandata da decenni e che è servita ad ottenere quanto abbiamo visto al punto precedente, cioè l’illusione che nella nostra società non esistano conflitti. Ma questo individualismo spinto ha come effetti collaterali innanzitutto di rendere più evidenti, quando emergono, i conflitti. Ed inoltre confligge con la solidarietà che invece è importante anche per continuare a credere che i conflitti non ci sono. Si tratta di garantire quel tanto di solidarietà che può essere utile a superare momenti difficili. Solo che è facile dire “America first” o “Prima gli Italiani”: il problema è trovare un elemento che permetta di individuare un “noi” in modo che ci distingua chiaramente da “loro” rispetto ai quali siamo meglio, così da giustificare perché ci meritiamo di avere la precedenza. Infatti affermare che siamo meglio degli altri non è il risultato di un discorso argomentativo, per il fatto che, come abbiamo visto, bisognerebbe mostrare che “noi” siamo più di “loro” conformi al Bene, ed essendo il Bene (scritto maiuscolo) un valore, sappiamo già che non lo possiamo neanche esprimere. Possiamo però trovare qualche ambito del nostro agire sul quale siamo d’accordo che è un bene (scritto minuscolo) ed al quale collegare alcuni dei criteri coi quali organizziamo i nostri comportamenti. Criteri che siano più o meno chiaramente localizzabili e che traggano da quel collegamento – magari non esplicitabile ma in qualche modo “visibile” – la conferma del loro valore. Se il problema è questo, allora lo sport è strumento eccellente perché è perfettamente trasversale alle diverse componenti sociali. Infatti la competizione ha certamente una connotazione positiva per tutti in quanto permette l’affermazione dell’individuo; inoltre questa competizione è incruenta, ed anche questo è un dato positivo, dal momento che quella competizione cruenta che è la guerra è un modo estremo di affermazione fortunatamente disapprovato dai più; inoltre il successo sportivo manifesta quella salute del corpo associata da millenni alla salute della mente. Se poi fosse possibile, ancorché in maniera non rigorosa, associare allo sport altri valori aggreganti si avrebbe un risultato veramente completo.

In effetti con le ultime Olimpiadi abbiamo assistito ad un continuo riferimento ad aspetti extra-sportivi e non solo nel caso degli atleti italiani. Un gran numero di atleti ha dedicato la medaglia ad un nonno o ha affermato di aver sentito il supporto di un nonno o dei genitori.
Un altro ambito sul quale si è posto l’accento è stato il fatto che alcuni atleti, benché fisicamente preparatissimi, hanno mancato la prestazione attesa o vi hanno rinunciato. Anche questo, che dovrebbe essere un fallimento, è stato sottolineato dai media: era la prova che gli atleti non sono semidei ma esseri umani nei quali ci possiamo riconoscere. In questi casi è stata fatta anche l’operazione di rivalutare in qualche modo la sconfitta, sottolineando come un eccesso di impegno, di concentrazione, di tensione verso il risultato eccezionale possa essere controproducente, suggerendo che il rapporto fra la salute della mens e quella del corpo che la ospita potrebbe essere inteso anche in maniera capovolta: se la mente non è in buona salute perché stressata da eccessive richieste rivolte al corpo, anche un allenamento perfetto non dà risultati. E questo ci ricorda situazioni in cui spesso ci troviamo.
E poi ci sono i casi eticamente più ammirevoli in cui la competizione, per quanto serratissima, non porta alla consacrazione del campione: due atleti risultano superiori a tutti gli altri ma non riescono a superarsi l’un l’altro, ed allora rinunciano alla competizione ed alla conseguente affermazione di sé e decidono di stare insieme sul gradino più alto del podio; splendida vittoria di amicizia, solidarietà e dell’idea che la competizione se certamente comporta la vittoria di uno non significa necessariamente la sconfitta dell’altro.
Fare questo tipo di retorica sullo sport ha risollevato le sorti di una serie di valori importanti per la vita della collettività: la competizione, certamente, e la capacità di sacrificio per ottenere il risultato, ma anche la famiglia, l’amicizia, la solidarietà, la capacità di accettare la sconfitta. Erano aspetti, gli ultimi, non strettamente sportivi ma che hanno ricevuto, dal fatto di essere associati alle competizioni, un alone di positività che, senza il legame con lo sport, potrebbe essere problematico attribuire loro.
Si tratta di un risultato che solo il ragionamento retorico poteva ricavare dallo sport, grazie al fatto che guardava non solo all’evento sportivo ma all’insieme dell’attività degli atleti e dunque anche agli aspetti affettivi, psicologici e sociali che fanno dello sport una componente non secondaria del nostro orizzonte culturale e dello sportivo un possibile modello di vita con tutte le responsabilità che questo comporta. Sicché si può affermare che ha senso tributargli (possibilmente senza esagerare) ricompense e onori se ha assolto ai suoi oneri.
D’altra parte anche nell’Atene del V secolo a.C. gli atleti che avevano vinto le Olimpiadi (ed altri cittadini benemeriti) venivano mantenuti (pranzavano quotidianamente: niente di paragonabile, dal punto di vista economico, a quello che ricevono gli atleti dei nostri tempi) a spese dello Stato nel Pritaneo, che era la sede dei “primi magistrati” delle antiche istituzioni cittadine nonché il luogo in cui era custodito il fuoco sacro, dunque il luogo moralmente più importante della città.
L’importante però, nell’utilizzare lo strumento retorico, è tener presente che accanto a tante potenzialità positive esso può anche essere lo strumento per imbrogliare l’uditorio. E su questo bisognerebbe vigilare.