Il concetto di tempo è tema filosofico per eccellenza. Sappiamo veramente cos’è il tempo? Possiamo veramente impadronirci di una nozione del tempo?
Procederò zigzagando tra alcuni libri in un percorso apparentemente discontinuo, fatto di spunti da raccogliere e ricucire a piacimento nel tentativo di formare una personale via di ricerca.
Come sostiene Carlo Rovelli (”L’ordine del tempo” Adelphi 2017) in fisica siamo arrivati a formulare equazioni fondamentali ove il tempo sparisce, passato e futuro non si oppongono più e semmai è il presente a dileguarsi (possiamo dunque interrogarci sul senso delle nostre preoccupazioni quotidiane, certamente destinate tutte a dissolversi, anche se rimane il fatto che con i problemi contingenti dobbiamo comunque confrontarci: se in questo momento ho fame in questo momento devo trovare da mangiare). Di fatto, a causa dei nostri deliri di onnipotenza, non vogliamo fare i conti con questo tipo di pensiero; assistiamo ogni giorno alla morte di tante persone, ma quelli che restano continuano a vivere come se fossero immortali (ed ecco i conflitti quotidiani e le guerre continue per accumulare potere e ricchezza, un accumulo assurdo e inutile dal momento che comunque non può durare per sempre).
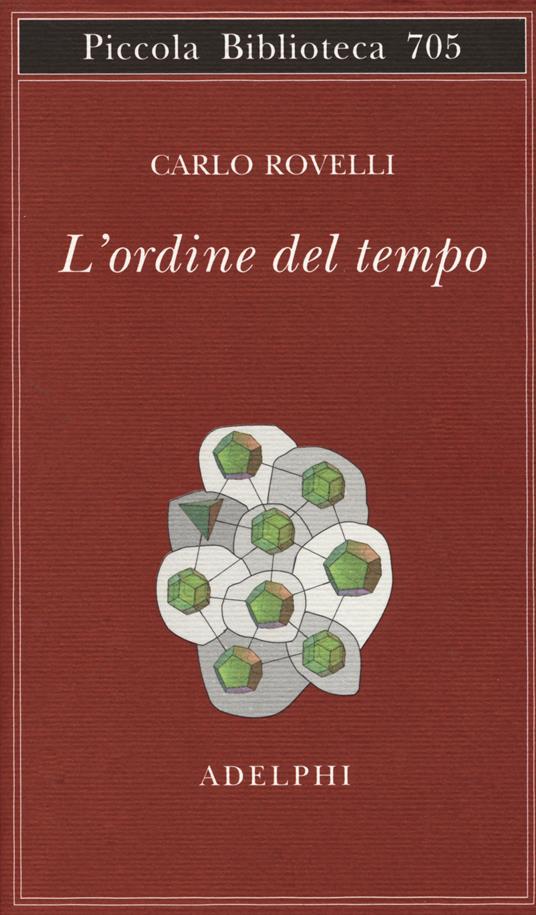
Abbiamo bisogno di creare strutture, e il tempo è una di queste, che ci diano sicurezze, ma non c’è alcuna sicurezza che non sia destinata a dissolversi. Non avremo mai una verità definitiva ed anche i nostri ricordi, di qualsiasi genere, sono destinati a diventare labili e confusi. Non è poi così vero che la storia mette giustizia nei fatti dell’uomo, se non in parte. Anch’essa è un prodotto umano con tutti i limiti conseguenti. Scrivendola non possiamo prescindere dalle nostre ”emozioni”, che sono sempre legate alla dimensione temporale del nostro animo: allora diventa difficile distinguere tra presente e futuro e da una non districabile mescolanza di fatti del presente e del passato possono affiorare i piani futuri della nostra storia. Così ci parla Filippo Mattino (”Scrivere per emozioni. Una guida per raccontarsi” Interlinea 2023), il quale sostiene pure che quando si scrive bisogna non tanto guardare al passato, col rischio di far prevalere lo sfogo personale, quanto far emergere scenari futuri; in qualche modo lasciar correre il tempo come tempo del sogno (ascoltiamo Delphine Horvilleur ”Capire il mondo” Qiqajon 2023).

Noi siamo abituati a pensare il tempo in modo lineare: forse dovremmo abituarci a concepirlo in modo circolare. Siamo veramente noi ad abitare il tempo o non è piuttosto ”lui”che ci sfugge continuamente? In ogni nostro attimo il passato non c’è già più e il futuro non c’è ancora, mentre il presente sfuma continuamente tra questo e quello.
Chiediamoci per quale motivo le fiabe cominciano sempre con ”c’era una volta”: il fatto è che il passato si ripete continuamente. Abbiamo bisogno di storie e di miti per non perdere le nostre radici. Ma, appunto, il bisogno di archetipi immutabili testimonia ancora una volta che ”non c’è un passato che non passa”, perché non c’è una storia lineare, ma un flusso continuo di quello che c’era, che c’è, che ci sarà.
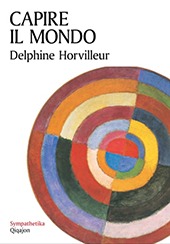
Una ”nostalgia del passato” può essere plausibile, può risultare anche interessante purché non diventi passatismo e cioè rifiuto di un presente dove nulla va bene per un improbabile ritorno a un ”passato che è passato”. Tale nostalgia può essere utile se implica il ricordo e il recupero di valori capaci di stabilire un legame tra il mondo di ieri e quelli di oggi e di domani. Siamo spesso portati a dire che ”era meglio prima”, ma cosa era meglio prima, cosa significa quel prima? Dobbiamo accettare di vivere in una progressione, senza rimpianti e senza fondamentalismi, con il senso di un percorso che non ha soluzione di continuità. Il mondo sta cambiando sempre più velocemente e questi cambiamenti così rapidi sfuggono al nostro controllo (può essere utile la lettura del volume di Rosa Hartmut ”Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo in tarda modernità” Einaudi 2015).

Ne deriva una particolare angoscia che può sfociare appunto in nostalgia, ma forse più che una improbabile nostalgia del tempo passato potrebbe essere l’aspirazione a un tempo futuro, un tempo in cui avremo più tempo.
Pensiamo alle nuove generazioni. Si interrogano i giovani su tutto questo, sentono questo bisogno, oppure sono disposti ad accettare acriticamente un futuro scollato da tutto ciò che è stato? Per loro, ma anche per noi, occorre proporre con ostinazione la lettura dei classici (interessante la lettura di Nuccio Ordine ”L’utilità dell’inutile. Manifesto” Bompiani 2013) e cioè di quei testi che non cessano mai di parlare alle persone che continuano a leggerli, quei testi che non finiremo mai di comprendere, quei testi che possono continuare a far crescere, appunto anche le nuove generazioni.

I classici possono salvaguardare l’idea di umanesimo, inteso come proposta di un’umanità condivisa, di vivacità culturale, di responsabilità etica e morale senza il bisogno di dogmi religiosi o politici o ideologici. I classici possono farci riflettere sui danni prodotti da un ”antropocentrismo” esasperato e ancora di più su quelli che potrebbero derivare da un ”tecnocentrismo” privo di ogni limite.
Con la realtà digitale siamo passati da una ”civiltà dialogica” fondata su un continuum tra passato- presente-futuro in costante rapporto dialettico a una sorta di ”civiltà dell’immediato” attenta solo al presente, un presente da consumare sempre e comunque. Un passaggio di civiltà che da un lato aumenta sempre più la ”comunicazione”, e cioè la quantità di notizie a disposizione, mentre dall’altro lato riduce sempre più la ”comunicatività”, col pericolo di impoverire gravemente i rapporti umani.
La lettura dei classici può permetterci di affrontare meglio la ”paura della morte”, un sentimento fortemente legato alla percezione di un tempo finito che invece finito non è. Andrea Spinelli (”Se cammino vivo. Se di cancro si muore pur si vive” Ediciclo 2018) è stato una persona eccezionale, capace di combattere per dieci anni un inguaribile cancro al pancreas senza mai perdere un approccio positivo alla vita: secondo lui la paura è ”il sangue della vita” ed è giusto nutrirla, è giusto che ci sia.

Come qualcuno ha detto è umano provare l’angoscia dell’ignoto, l’angoscia per una vita universale troppo grande per essere compresa dalla nostra mente così limitata. Ma poi ascoltiamo Carlo Rovelli sostenere che la paura della morte è ”un errore dell’evoluzione” (gli animali paiono non provarla) dipendente dal senso di un tempo definito, del nostro tempo destinato a finire. Ma questo è legato alla debolezza del nostro pensiero, un pensiero sostanzialmente limitato che può essere rivoluzionato in qualsiasi momento da una nuova scoperta, anche piccola, improvvisa, inattesa. Basta poco perché tutto possa cambiare, anche il nostro modo di concepire il tempo e la fine. Abbiamo parlato di angoscia e cioè di qualcosa che può anche tradursi in una ”paura dell’ignoto”: anche il materialista, anche chi nutre l’idea che ”dopo non ci sarà più nulla”, può provare un senso di sbigottimento rispetto a ”questo tutto che finisce per sempre”. Fine di ogni nostro sforzo, di ogni nostra preoccupazione, di ogni nostra prospettiva. Non resterà più nulla se non la memoria degli altri, di quelli che ci sopravviveranno. Rimarrà un ricordo di noi che non sarà positivo per tutti, forse lo sarà per pochi, forse per qualcuno senza troppe ombre. Un ricordo come misura del nostro operato, dei nostri limiti, delle nostre riuscite, dei nostri fallimenti, comunque di qualcosa ormai immutabile. E’ abbastanza normale che pensare a tutto questo determini un senso di angoscia, soprattutto se si nutre il timore di non aver fatto abbastanza e dunque di aver sprecato, poco o molto, le nostre occasioni.
Dovrebbe derivarne il bisogno di una visione della realtà che si ponga in un continuo divenire, sempre parziale e limitata, sempre attenta a non sfociare in forme di delirio personale e collettivo, sempre capace di trovare giuste mediazioni e correzioni.
E qui termina questo mio procedere per frammenti, probabilmente abbastanza sconnesso, ma avente l’unico scopo di offrire alcuni spunti di riflessione.
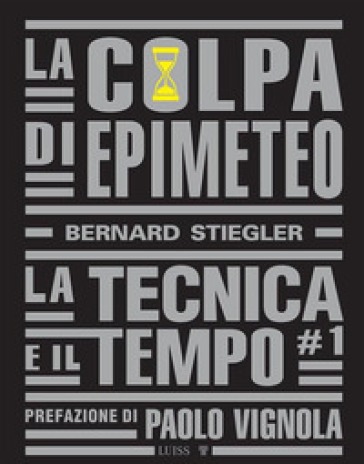
Segnalerei un ultimo libro: ”La tecnica e il tempo. Vol.1. La colpa di Epimeteo” di Bernard Stiegler, edito quest’anno da Luiss: potremmo chiederci fino a che punto il nostro tempo può essere inteso come un succedersi di infiniti passaggi da una atemporalità assoluta ad una assoluta atemporalità; ma più ancora, abbandonando quelle che possono apparire come speculazioni linguistiche e filosofiche, dovremmo interrogarci sui gravi danni prodotti finora dal nostro ”antropocentrismo” e su quelli ancora più gravi che potrebbero essere prodotti in futuro da un esasperato ”tecnocentrismo: qui c’è poco da speculare e occorrerebbe ricominciare da capo tutta la nostra riflessione.


